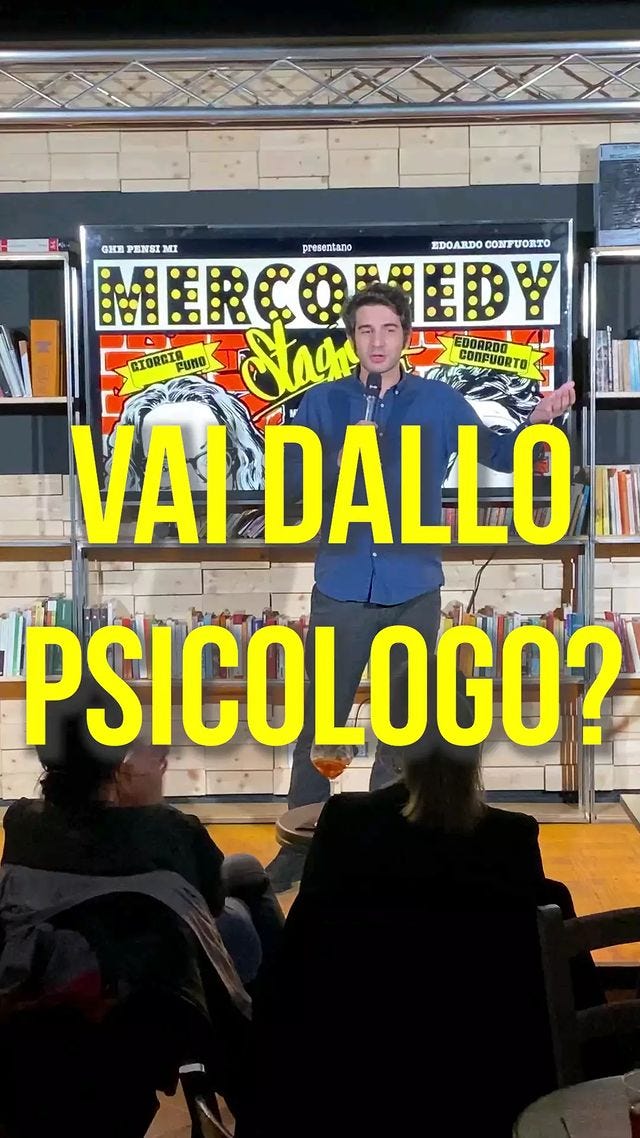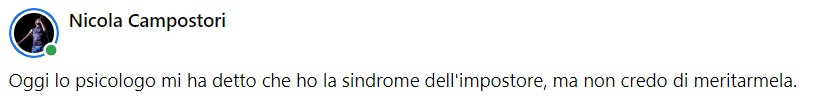Analisi comica dell’analisi e dei comici
Quante volte abbiamo sentito un comedian dire che il suo mestiere è come una seduta di terapia ma, invece che dare soldi allo psicologo, è lui ad esser pagato dal pubblico?
Il legame tra analisi e comicità è quasi un luogo comune, grazie anche al nume tutelare dei comici di tutto il mondo, Woody Allen, che ha fatto del suo rapporto con gli eredi di Freud un tòpos del suo universo poetico. Tra parentesi, mi piace sempre sottolineare come, dopo anni di sedute, Allen abbia sposato la propria figlia adottiva: ci si potrebbe chiedere cosa avrebbe fatto se NON avesse fatto terapia.
Una piccola annotazione: se stai leggendo queste righe perché ti senti depresso, o hai la sensazione che ci sia qualcosa che non vada, il mio consiglio è di parlarne con un amico e di rivolgerti a uno psicologo. Sembra una banalità, ma ti può aiutare.
Molti dei comici che conosco vanno dallo psicologo, e a volte in effetti ho l’impressione che la percentuale di persone in terapia sia più alta tra i comedian; ma questa percezione deriva almeno in parte dal fatto che i comici sono tra quelli che ne parlano più apertamente, perché raccontare la propria vita privata fa parte del loro lavoro. Magari anche il panettiere sotto casa, la cassiera del supermercato, l’insegnante di tua figlia, tutti quelli che incontri ogni giorno vanno dallo psicologo, però capita raramente che il salumiere di fiducia ti dica: “Ho fatto un etto e mezzo, lascio? E a proposito, sono in terapia”.
Al di là delle statistiche, però, potrebbe esserci del vero nel ritenere quella dei comici una categoria più soggetta all’analisi. Innanzitutto, in quanto artisti, essi tendono a spendere molto tempo nel riflettere su sé stessi e sul mondo e quindi sono in qualche modo più allenati rispetto ad altri ad includere nella quotidianità il confronto con la propria interiorità e con la realtà esterna, confronto che appartiene anche alla terapia, che per i comici sarebbe quindi uno strumento in più per fare quello che già fanno, ragionare su chi sono e sul rapporto con chi sta loro attorno.
Non ricordo dove l’ho letto ma sono d’accordo che l’arte sia la risposta di chi sente che la realtà sia imperfetta: se vivessimo in totale sintonia col mondo probabilmente non sentiremmo la necessità di dipingere, scrivere canzoni, preparare monologhi comici. Se fare l’artista è dunque sintomatico di un qualche conflitto personale, desiderare nello specifico di essere comedian significa volere esporsi al pubblico in maniera disarmante e cercare costantemente il consenso degli altri: semplificando e generalizzando un po’, può essere indice di un certo peculiare squilibrio interiore, di una mancanza che vuole essere colmata con la performance dal vivo, di un disagio rispetto alla normale convivenza sociale. Non sono di quelli convinti che i clown siano tutti tristi, ma ritengo che spesso dentro al comico ci sia un tormento (più o meno forte, più o meno esistenziale) che si placa solo sul palcoscenico. E’ quindi naturale che spesso quel tormento porti il comedian ad affrontare un percorso di terapia.
Nel documentario Laughing matters, che consiglio, viene chiesto a undici comici di parlare della loro storia tra comicità e salute mentale. Tra le molte cose degne di nota che vengono dette, Neal Brennan afferma che se l’ignoranza è benedetta allora anche il contrario dev’essere vero, intendendo che se ti avvicini alla verità ti deprimi. Anche in questo caso, non sono sicuro che vedere il mondo per quello che è implichi per forza maggiore tristezza, ma è condivisibile il pensiero che interrogarsi sulle dinamiche che governano la società in cui viviamo può portare a una visione più pessimista rispetto a quella di chi non si pone domande.
Va aggiunto che la pressione che il mondo dello spettacolo esercita sui comici sicuramente non li aiuta a mantenere l’equilibrio, e se questo è più evidente nei comedian di successo, che sono sempre sotto i riflettori in un ambiente ipercompetitivo e attorniati da fan con grandissime aspettative e da hater pronti ad attaccare ferocemente, credo che valga con le dovute proporzioni anche ai livelli più bassi, tra i comici che lottano per avere uno spot nel locale giusto o cinque minuti in un talent che potrebbe cambiare loro la vita.
In superficie, quello che avviene sul palco sembra essere simile a ciò che succede sul lettino: una persona che si confronta con le proprie insicurezze e tensioni irrisolte. Ciò è ancora più accentuato in quel tipo di comicità, che ultimamente ha preso sempre più piede, basato proprio sull’esposizione delle fragilità o sul rievocare traumi passati, da una violenza subita alla morte di un affetto. Ma a ben vedere esistono grandi differenze tra analisi e comicità.
Teniamo innanzitutto a mente che lo scopo della comicità è far ridere: se un comedian decide di dire qualcosa sul palco è perché pensa che possa suscitare divertimento negli spettatori. Ammettiamo pure che urlare le proprie frustrazioni in un microfono sia in una certa misura liberatorio e quindi possa servire a far stare meglio chi lo fa, non va però dimenticato che un comedian che si limitasse a questo, senza valutare se quello che dice sia divertente e senza strutturare il proprio flusso di coscienza affinché lo sia, sarebbe un fallimento dal punto di vista comico. Nella stand-up, insomma, c’è l’aspetto performativo: quello che porti in scena deve trovare l’apprezzamento del pubblico, quindi va incasellato in una certa direzione; la terapia, invece, non ha uno scopo ulteriore al benessere del paziente e dunque non si preoccupa di come emerge la sua interiorità, la accetta così com’è proprio perché è il materiale su cui deve lavorare e quindi meno è censurata più facile sarà intervenire.
Nonostante lo stand-up comedian comunichi attraverso la forma del monologo, la dimensione del live è dialogica: il comico ha sempre un riscontro dal suo interlocutore, il pubblico; inoltre, ma questa è solo una mia opinione, i più bravi sono quelli che coinvolgono gli spettatori (non per forza interpellandoli), che reagiscono alle loro risposte, che permettono al qui e ora di modellare i propri pezzi. In ogni caso, il repertorio portato in scena viene sottoposto al vaglio degli spettatori, che ne possono confermare o smentire la validità approvandolo o rifiutandolo (con mille sfumature in mezzo). Parallelamente a questo aspetto relazionale, la stand-up comedy possiede però anche un’anima molto ego-riferita, perché spinge a concentrarsi su sé stessi, a dare importanza a ciò che si pensa: i feedback della platea possono sì modificare il repertorio del comico, ma quei cambiamenti sono pur sempre mossi dal tentativo di trovare il modo migliore per vedere approvata la propria idea, i propri pensieri. L’appagamento per una risata o per l’applauso degli spettatori è estremamente gratificante proprio perché è un riconoscimento intimamente personale per il comedian che lo riceve. Da parte sua, l’analisi è più profondamente dialettica, perché entrare in terapia significa (anche) lasciare che un punto di vista esterno ti aiuti a mettere davvero in discussione la tua visione di te stesso e del mondo; in questo caso l’intervento dell’altro da sé (lo psicologo) non è confermativo, ma trasformativo.
Credo che la stragrande maggioranza degli insegnanti di comicità sia concorde nel dire che per poter ridere di qualcosa bisogna prima averla elaborata. Ammetto che per molto tempo questo assunto non è stato scontato per me: proprio perché credevo nel valore terapeutico della comicità, ogni volta che mi capitava qualcosa di importante a livello emotivo sentivo l’urgenza di farlo diventare materiale da portare sul palco, così come ho sempre pensato che scherzare sulle “cose brutte” che ci capitano e sui propri lati oscuri sia un modo per includerli nel dicibile, per condividere la propria umanità con gli spettatori e quindi per riuscire a vincere temporaneamente sui colpi bassi della vita, ad accettarsi e accettare meglio gli altri. Resto convinto di questo potere della comicità, ma ora capisco che esporre i propri aspetti problematici al pubblico senza saperli maneggiare oltre a non esser garanzia di comicità non è neanche paragonabile all’analisi: la psicoterapia non è semplicemente tirar fuori quello che abbiamo dentro (cosa che si può fare sul palco mettendosi sempre meno filtri) ma elaborare quei sentimenti e quel vissuto con l’aiuto di un/una professionista (cosa che sul palco non può essere fatta).
Terapia e comicità allora non sono alternative tra loro: per un comedian la prima può essere un processo propedeutico alla possibilità di scherzare su cose che senza l’analisi rimarrebbero territori troppo insicuri per costruirci sopra dei joke.
Da quando ho iniziato a riflettere su questi temi, mi sono reso conto di una cosa: migliorare sul palco, essere più spigliato (anche nel trattare temi delicati e personali) non mi ha aiutato minimamente a superare i miei complessi nella vita reale. Con tutto che la stand-up è sincerità, si tratta comunque di una forma d’arte e quindi di finzione; sul palco ci saliamo nudi, ma siamo comunque protetti dall’aura che il nostro ruolo emana in quel momento. La libertà della quale godiamo sul palco, il benessere che ci pervade nell’affrontare le nostre paure a viso aperto e col sorriso vivono in un momento di sospensione, che termina quando finisce la performance. Mentre ci esibiamo non stiamo davvero intervenendo sui meccanismi che regolano la nostra mente quando si tratta di relazionarsi agli altri nei normali contesti di interazione sociale, né stiamo cambiando le nostre abitudini dannose. Affrontare le proprie difficoltà nel mondo è tutt’altra cosa rispetto a saper divertire raccontandosi con onestà, e per farcela serve un percorso (quello terapeutico appunto) diverso dalla gavetta di comico. Sicuramente cercare la parte divertente delle cose è un’attitudine che a più di un livello può fare bene ma, come dice Chris Gethard in Laughing matters, la comicità non ti salverà e se stai pensando di fare comicità in sostituzione alla terapia, non funzionerà.
Nel documentario appena citato, Sara Benincasa afferma che rispetto alle altre persone i comici sono più onesti sull’ammettere di essere “fucked up”. L’essere comedian, quindi, implica non solo il rendere pubblico aspetti della propria vita come l’andare in terapia e una consapevolezza maggiore su ciò che si prova ma anche una più forte capacità di accettare le proprie debolezze. Ho già detto che è proprio questo ad avermi fatto innamorare della stand-up, e non ho intenzione di sminuire il valore immenso che dò a questa sua caratteristica. Però ultimamente ho cominciato a scorgere qualche sfumatura e ambiguità: quando l’accettazione di sé stessi diventa autoindulgenza? Esiste un punto in cui venire a patti coi propri difetti si trasforma in una scusa per non provare a migliorare? Dobbiamo davvero accettare tutto quello che siamo, oppure ci sono aspetti di noi che possono cambiare? E soprattutto, quale delle due cose, l’accettazione e il cambiamento, ti fanno stare meglio nel lungo termine?
Ovviamente la risposta a tutte queste domande varia da persona a persona e ognuno deve trovare la sua misura tra un polo e l’altro. Potrebbe essere utile fare propria questa considerazione di Sarah Silverman, tratta ancora da Laughing matters: “Non c’è niente di più importante per me dell’essere divertente, eccetto lo stare bene”.
Segnalazioni
Rimanendo in tema: sul sito di Esquire c’è un profilo di Alan Lefkowitz, lo psicologo dei comici, che tra le altre cose sfata il mito che un comico felice sia un comico meno divertente.
Jack Bernhardt propone lezioni obbligatorie di stand-up per tutta la popolazione, “so that we can all think more like comedians and save our society”.
Jimmy Carr è stato citato in giudizio per diffamazione da suo padre.
L’angolo autoreferenziale
Dove vedermi live
Ho rimesso mano al mio primo one man show, Nutro i miei dubbi, tagliando parti che ormai non aveva senso riproporre, aggiungendo pezzi che col tempo sono diventati importanti per me, cesellando tutto per provare ad avere un’ora di materiale bello forte. Ci sarò riuscito? Nei prossimi giorni avrò qualche occasione per scoprirlo, dato che porterò il monologo intero nei seguenti locali: domani, 20 ottobre, a El Paso Saloon di Pianengo, con l’apertura di Mattia Rellini; mercoledì 2 novembre al Wipe Out di Paderno Dugnano, presentato da Nemo Barbieri e introdotto da Mattia Targhetti; giovedì 10 novembre alla Teeria Passaggi di Tempo di Vigevano (grazie a Mario Raz); sabato 12 novembre alla Birreria Majnoni di Erba, preceduto da Giorgio Brambilla e Pietro Dell’Acqua.
Questa sera invece non perdetevi la Wipe Out Comedy (sempre a Paderno Dugnano) con Luca Anselmi, Stefano Borghetti e Denny Cavalloni. Venerdì 21 mi trovate alla serata del Circolo San Luis, ospite di Matteo Zaffarano, sabato 22 presento la Monza Comedy Night, in un episodio crossover con Crime&Comedy: sul palco i due comici podcaster Clara Campi e Marco Champier e l’intermezzo di Michela Altieri. Lunedì 24 torno con gioia all’open mic del Nemico a Milano.
Non è finita: mercoledì 26 mi esibirò al Comala di Torino con Luca Anselmi, thanks to Stefano Gorno; giovedì 27 avrò l’onore e il piacere di sostituire Natalia Vasilishina alla conduzione dell’open mic al Bachelite CLab di Milano. Sabato 29 porto alla Birreria Majnoni il one man show di Antonio Ricatti con Matteo Adami in apertura; lunedì 31 partecipo all’open mic di Halloween organizzato allo Spank (sempre a Milano, sempre gestito da Luca Anselmi); venerdì 11 novembre condividerò il palco del Circolo Arci Belleri di Piacenza con Laura Pusceddu e Andrea Chiappini, che ringrazio per l’invito. Quest’ultimo sarà poi con Richi Selva al Wipe Out mercoledì 16 novembre, assieme a Ivano Steri. Nel frattempo, lunedì 14 novembre, ci sarà stata un’altra serata degli Scomedy Four al meneghino Garage Moulinski.
Il video alla fine
Stand Up Comedy is NOT Pretty è una serie che mostra in maniera ironica l’ambiente della comicità. La prima puntata è dedicata ad un duello archetipo, quello tra comedian e gestore del locale.
Great, that sounds fair. Alla prossima!