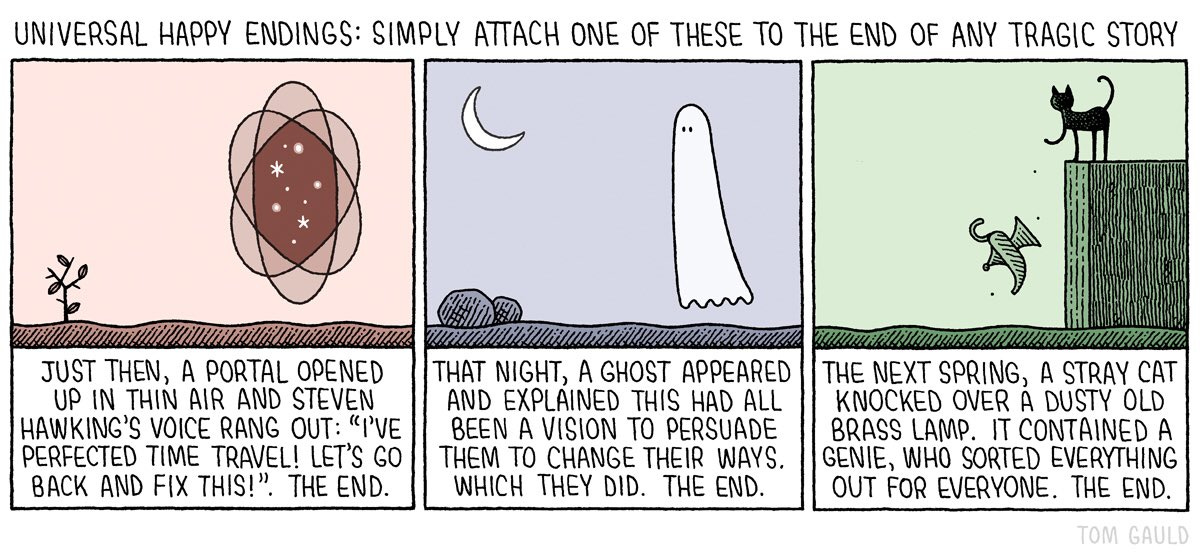Tanti auguri, Groucho!
Esattamente un anno fa, il 19 agosto 2020, ho pubblicato la prima puntata di Tendenza Groucho. La scelta del giorno è stata casuale; solo a posteriori ho scoperto che in quella data del 1977 moriva il più celebre dei fratelli Marx e non mi è dispiaciuta la coincidenza, ulteriore omaggio a questo gigante della comicità. Scelsi la cadenza mensile perché sapevo che non sempre avrei avuto tempo per uscite più frequenti, ed in effetti devo dire che a volte mi sono trovato in difficoltà anche con una sola pubblicazione ogni trenta giorni. Finora comunque ce l’ho fatta. In questo anno di newsletter ho intervistato comiche e comici, presentato iniziative meritevoli, ragionato su temi legati alla stand-up cercando sempre di tenere il dibattito aperto, in modo che le riflessioni di Tendenza Groucho fossero un punto di partenza e non di arrivo. Ho ricevuto consigli e apprezzamenti, e in alcuni casi sono riuscito a stimolare lunghe e interessanti discussioni.
Ora mi sento in una posizione ambigua: da una parte sono consapevole che con queste tredici puntate ho appena cominciato a sondare l'universo comicità, che contiene al suo interno talmente tante sfaccettature che non basterebbe una vita intera di newsletter per commentarle tutte; dall’altra comincio a interrogarmi su come proseguire questa avventura, provando a produrre ogni volta contenuti valevoli. Cosa riserverà Tendenza Groucho in futuro? Qualche idea inizia a frullarmi nella testa. Oltre alle rubriche che ho già proposto, credo ad esempio che nei prossimi mesi proporrò recensioni di spettacoli. È saltata fuori anche la proposta di interviste e dibattiti filmati, chissà…
Mi piacerebbe sentire il vostro parere. Cosa vi è piaciuto sinora? Cosa invece va migliorato? In generale, cosa vorreste leggere su Tendenza Groucho?
Ed ora, spente le candeline, iniziamo a trattare l’argomento di oggi, ispirato da un botta e risposta su Facebook suscitato da un mio vecchio post.
Lots of laughs
Che il comico debba far ridere sembrerebbe scontato, ma se vi prendete la briga di parlare coi diretti interessati, scoprirete che c’è chi contesta questo assunto. Nella stand-up, che si è sempre vantata di proporre contenuti divisivi e quindi di cercare (anche) di shockare il pubblico, diverse persone contestano la risata come fine del proprio lavoro; il loro scopo sarebbe invece veicolare concetti scomodi i quali, lungi dal generare ilarità negli spettatori, li mettano a disagio.
Laddove la risata è reazione di pancia, incontrollabile, istintiva per eccellenza (tanto che non la si può fingere), l’applauso sembrerebbe un obiettivo più consono per il comedian che vuole far riflettere: per metabolizzare un pensiero il pubblico necessita di più tempo, e l’applauso è proprio un commento “di testa”, più ragionato e mediato, che arriva dopo un istante di elaborazione. D’altra parte l’applauso è espressione di consenso, che si può ottenere solo dicendo al pubblico qualcosa che già approva, il che sembrerebbe rendere anche il battito di mani poco auspicabile dal monologhista che vuole porsi controcorrente e stuzzicare l’audicence con tesi provocatorie.
Al di là del fatto che per alcuni comici, in particolare gli esordienti, sostenere di non cercare la risata sia un modo (umanamente comprensibilissimo) per rifiutare il giudizio del pubblico che col tempo si trasforma in una più discutibile propensione a non mettere in discussione il proprio lavoro e il proprio livello, penso che questa concezione che vede come unico scopo del vero comedian la veicolazione di contenuti provocatori e che rifiuta di definire comicità qualsiasi altra forma non rispetti questo mandato si scontri in maniera evidente con la prassi: nella realtà, nessun comico, neanche il più estremo, sale sul palco sperando di non far ridere o di non ricevere applausi.
Ammetto però che basarsi solo sul far ridere come criterio per stabilire se un’opera è comica o no rischia di attribuire troppa importanza a qualcosa, la risata del pubblico, che non dipende solo dal comico. Sappiamo bene infatti che ci sono pezzi che a volte fanno ridere e a volte no, pezzi che dividono il pubblico in entusiasti e indifferenti, pezzi che hanno bisogno di una platea specifica per funzionare… Una definizione più valida di cosa è comico non dovrebbe basarsi sull’effetto, che non è controllabile, e infatti ciascuno ride per cose diverse, ma sull’intento, che invece è totalmente nelle mani dell’autore. Anche sull’obbiettivo che il comedian deve porsi c’è però grande divergenza di opinioni; per spiegare perché ritengo invece che su questo punto non ci sia molto da discutere devo prenderla un po’ larga, partendo dalla specificità del genere comico.
Ora, disquisire sulla natura di tragedia e commedia richiederebbe tempo e soprattutto conoscenze che non ho. Posso però avvicinarmi alla questione in maniera tangenziale, partendo da alcune considerazioni fatte da Daniele Luttazzi (sempre lui) nei suoi articoli domenicali per Il Fatto Quotidiano. Egli insiste più volte sul fatto che la comicità è luogo di numerose dialettiche. Se è vero che anche la tragedia propone contrapposizioni, a differenziare i due generi è il modo col quale gestiscono la tensione fra Anthropos e Cosmos, ovvero tra natura e cultura: nella tragedia essa non viene annullata, trionfa la natura, il destino, il caos e nello spettatore si genera un effetto di disforia; nella commedia invece quella tensione viene annullata (cioè trionfa la cultura, l’uomo, la società) e nel pubblico si genera un effetto di euforia. “Le gag sono euforizzanti” conclude Luttazzi “Ogni risata è un trionfo temporaneo sul destino”.
Prendiamo ad esempio l’Otello di Shakespeare e il George Dandin protagonista dell'omonima opera di Molière. Sono entrambi personaggi gelosi, ma perché il primo si trova al centro di una tragedia mentre il secondo vive in una commedia ai limiti della farsa? La risposta che più mi sembra attinente a quanto sto cercando di dimostrare è che la gelosia di Otello ha conseguenze drammatiche, che culminano nell’uccisione di Desdemona e nel suicidio del protagonista, mentre quella di Dandin ha il solo effetto di rendere ancora più ridicolo un personaggio mosso da interessi meschini. Seguendo lo schema proposto da Luttazzi, la morte di Desdemona rappresenta la vittoria del Cosmos sull’Anthropos (l’uomo Otello, ingannato da Iago, non riesce a leggere correttamente un universo oscuro, e questa incapacità genera la tragedia), mentre il Dandin cornuto e mazziato sancisce la punizione di una categoria di persone dannose per la società, ovvero chi, senza meriti, ha come unico scopo l’ottenimento dello status symbol del titolo nobiliare. Il finale di Otello mantiene la tensione, quello di Dandin la scioglie.
Nello show Annihilation, Patton Oswalt racconta l’improvvisa morte della moglie e la difficoltà di affrontare il tragico evento con la figlia piccola. Vi sono ovviamente momenti commoventi, che spingono alle lacrime, ma il comedian riesce anche a strappare più di una risata perché, ad un anno da quella dolorosa scomparsa, condivide col pubblico l’assurdità delle situazioni in cui si è trovato, la fragilità che lo ha travolto, le emozioni che ha provato riuscendo a mostrarle nei loro aspetti ironici e addirittura in quelli divertenti. Oswalt ha saputo insomma comporre un materiale potenzialmente tragico in maniera comica, ottenendo un monologo che celebra la forza di un piccolo uomo nella sua battaglio contro l’assenza di senso del mondo, una forza che contagia gli spettatori sciogliendo la tensione che avevano accumulato in un rito liberatorio che riesce a superare anche la paura della morte.
Riconosco che ci sono casi problematici: se la commedia è il luogo dove si risolvono le tensioni, come inquadrare gli schlimazel (figure tipiche dell’umorismo ebraico caratterizzate da perenne sfortuna ai quali capita di tutto) e i loro simili, che fanno ridere proprio perché subiscono il trionfo del Cosmos senza rivolgimenti positivi? Una risposta la potremmo cercare nelle diverse costruzioni dei personaggi. Gli autori hanno a disposizione una serie di mezzi per incanalare l’interpretazione del pubblico sui binari che vogliono. Otello ci viene presentato con una statura morale incommensurabile, Dandin è dipinto sin dall’inizio come un inetto e questo ci porta a leggere in maniera differente le loro disgrazie. Nulla vieterebbe di raccontare le vicende di Dandin come la tragedia di un marito che subisce soprusi dalla famiglia della moglie soltanto perché egli appartiene a un ceto inferiore; nulla se non appunto l’intenzione di Molière, abile nel tratteggiare il protagonista in modo che il pubblico sposi il punto di vista dell’autore sulla società che descrive.
Per quanto riguarda le vittime dello slapstick, inoltre, probabilmente lo spettatore percepisce lo scioglimento della tensione in quanto si sente al riparo dalle botte che ha preso il protagonista e perché riconosce che non sono botte vere. È la cosiddetta teoria della violazione benigna, ben spiegata qui. Resta comunque un margine di ambiguità, incarnato alla perfezione da Fantozzi, che da molti viene percepito come tragico, non riuscendo a ridere di ciò che gli succede.
Detto che questi ed altri casi, di estremo interesse, andrebbero affrontati separatamente, ritengo che siamo giunti al punto centrale per dirimere la questione su come si possa stabilire se un’opera sia comica: l’autore deve avere utilizzato un apparato tecnico e stilistico che conduca il lettore o lo spettatore verso lo scioglimento della tensione e il conseguente rilascio di una qualche forma di euforia, allegria, contentezza. Adottare questo parametro consente tra l’altro di evitare un’altra semplificazione: neanche l’intento è sufficiente affinché un’opera sia comica, è necessario un lavoro di costruzione le cui componenti possono essere rintracciate a posteriori in un’analisi critica del testo.
La risata a questo punto sarebbe uno degli esiti possibili di questo processo creativo, ma non l’unico e non quello imprescindibile. Caspita, sono finito così per ammettere l'obiezione di chi non considera la risata elemento necessario perché un’opera sia comica, e devo dire che non me l’aspettavo. Mi rimane però la diffidenza nei confronti dei comici che proclamano di non voler far ridere, perché mi sembra che nella maggior parte dei casi assieme alla risata eliminino anche la costruzione tesa allo scioglimento della tensione e che si limitino a urlare cose spiacevoli ritenendo che sia comicità. Se ciò che ho scritto finora ha un senso, per essere davvero comici quei contenuti vanno invece preparati in un certo modo. Il comico che sale sul palco per “dire la verità” lo farà comunque plasmando quella verità in modo che risulti evidente la sua intenzione euforica.
Mi pare che inquadrando la questione in questi termini, si ristabilisca il giusto peso alla risata (non un automatismo fine a se stesso, ma effetto dell’irrinunciabile scioglimento della tensione) e si risolva l’apparente cortocircuito che sembrava crearsi tra la provocazione e la ricerca del consenso del pubblico: il contenuto può essere estremamente crudo, ma il comedian cercherà sempre di offrirlo al pubblico in maniera distensiva. Ciò vale anche nella stand-up più corrosiva perché, come dice Greg Wilson in questa clip, “This is not stand-up commentary, this is not stand-up pontificating, this is stand-up comedy”.
L’angolo autoreferenziale
Il 19 agosto è anche il mio compleanno. E quello di Nanni Moretti. Se credete nel destino, fatemi sapere cosa questo possa significare.
Dove vedermi live
Let’s wait a little longer, ok?
Segnalazioni
Il 31 agosto in America debutta su Hulu Only Murders in the building, una nuova serie dai toni crime con protagonisti due miti della comicità, Steve Martin e Martin Short.
C’è grande eccitazione per il ritorno alla stand-up di Eddy Murphy, che negli anni ‘80 prima di diventare una star del cinema si era distinto come una delle più importanti voci black della comicità in piedi. Per l’occasione, stanno girando anche un documentario che ripercorrerà la carriera da monologhista di Murphy fino a questo atteso nuovo (e pare ultimo) suo show.
Consiglio Humorism, “A newsletter about labor, inequality, and extremism in comedy”. Affronta temi scottanti all’interno del panorama comico, principalmente statunitense, puntando i riflettori sui lati oscuri di questo ambiente.
Il video alla fine
Mi era piaciuto molto questo video e, quando ho avuto l’occasione di essere al Fringe di Edimburgo nel 2019, sono andato a vedere Shazia Mirza dal vivo in una delle venue del mitico The Stand. La serata è stata molto particolare e sarebbe valsa la pena raccontarla, se all’epoca avessi avuto una newsletter come questa.
Ricordatevi, se vi va, di farmi sapere come vi immaginate la Tendenza Groucho del futuro. ¡Saludos!